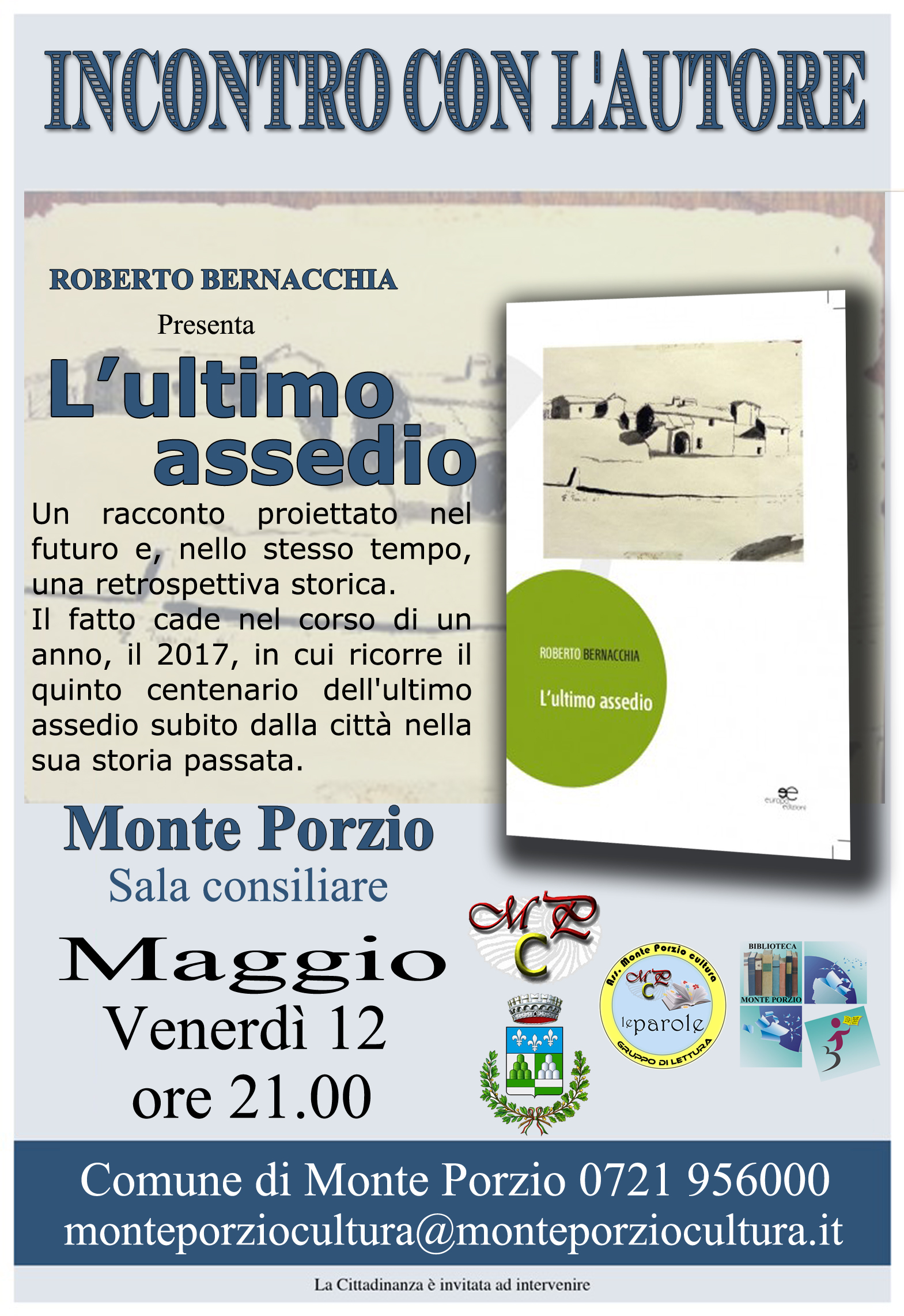Incontri con l’Autore 2012 – 2017
Locandine degli "Incontri con l'Autore" organizzati dal Gruppo di Lettura "le parole" nel periodo 2012–2017.
Con questo video auguro Buon Anno a tutto il gruppo e a tutti gli amanti della lettura.
BUON 2018
Gruppo di Lettura – incontro 16 gennaio 2018
L'amore arriva come un'onda, cancella ogni bugia, ti travolge e ti illumina.
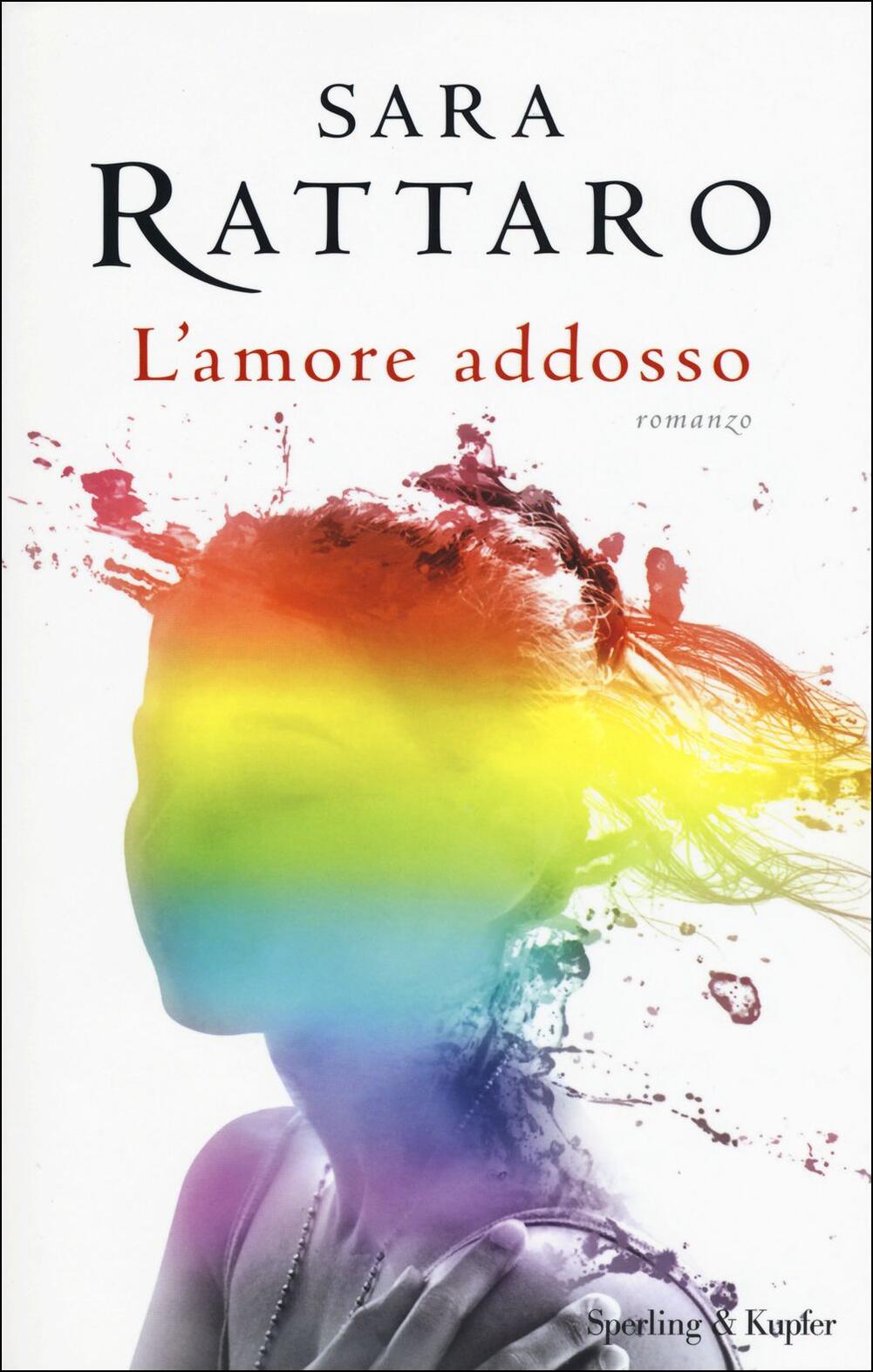 Una giovane donna attende con ansia fuori da una stanza d'ospedale. È stata lei ad accompagnare lì d'urgenza l'uomo che ora è ricoverato in gravi condizioni. È stata lei a soccorrerlo in spiaggia, mentre passava per caso, dice. Non dice – non può farlo – che invece erano insieme, che sono amanti. Lo stesso giorno, in un'altra ala dell'ospedale, una donna è in attesa di notizie sul marito, vittima di un incidente d'auto. Non era con lui al momento dell'impatto; non era rintracciabile mentre la famiglia, da ore, cercava di mettersi in contatto con lei. E adesso, quando la informano che in macchina con il marito c'era una sconosciuta, non sembra affatto stupita. La prima donna è Giulia. La seconda è ancora Giulia. E il destino, con la sua ironia, ha scelto proprio quel giorno per fare entrare in collisione le due metà della sua vita: da una parte, quella in cui è, o sembra, una moglie fortunata e una figlia devota; dall'altra, quella in cui vive di nascosto una passione assoluta e sfugge al perbenismo di sua madre – alle ipocrisie, ai non detti, a una verità inconfessabile. Una verità che perseguita Giulia come una spina sotto pelle; un segreto che fa di lei quell'essere così tormentato e unico, luminoso e buio; un vuoto d'amore che si porta addosso come una presenza ingombrante, un caos che può soltanto esplodere. Perché l'amore è una voce che non puoi zittire e una forza che non puoi arrestare. L'unica spinta che può riportarti a ciò che sei veramente.
Una giovane donna attende con ansia fuori da una stanza d'ospedale. È stata lei ad accompagnare lì d'urgenza l'uomo che ora è ricoverato in gravi condizioni. È stata lei a soccorrerlo in spiaggia, mentre passava per caso, dice. Non dice – non può farlo – che invece erano insieme, che sono amanti. Lo stesso giorno, in un'altra ala dell'ospedale, una donna è in attesa di notizie sul marito, vittima di un incidente d'auto. Non era con lui al momento dell'impatto; non era rintracciabile mentre la famiglia, da ore, cercava di mettersi in contatto con lei. E adesso, quando la informano che in macchina con il marito c'era una sconosciuta, non sembra affatto stupita. La prima donna è Giulia. La seconda è ancora Giulia. E il destino, con la sua ironia, ha scelto proprio quel giorno per fare entrare in collisione le due metà della sua vita: da una parte, quella in cui è, o sembra, una moglie fortunata e una figlia devota; dall'altra, quella in cui vive di nascosto una passione assoluta e sfugge al perbenismo di sua madre – alle ipocrisie, ai non detti, a una verità inconfessabile. Una verità che perseguita Giulia come una spina sotto pelle; un segreto che fa di lei quell'essere così tormentato e unico, luminoso e buio; un vuoto d'amore che si porta addosso come una presenza ingombrante, un caos che può soltanto esplodere. Perché l'amore è una voce che non puoi zittire e una forza che non puoi arrestare. L'unica spinta che può riportarti a ciò che sei veramente.
Gruppo di lettura – incontro 12 dicembre 2017
Le nostre anime di notte
Kent Haruf
Le nostre anime di notte è il sigillo perfetto all’opera di uno dei grandi interpreti della letteratura americana contemporanea.
«"Le nostre anime di notte" è un libro di assoluta semplicità, senza fronzoli, che comincia in medias res.» – Matteo Persivale, Corriere della Sera

«Per molti anni della sua vita di scrittore, Kent Haruf è partito per un luogo lontano. E sembra che prima di partire si abbassasse sopra agli occhi un berretto di lana, in modo da scrivere alla cieca. Batteva le dita sui tasti senza vederli, senza controllare le parole che andavano sfilando sul foglio, senza preoccuparsi della punteggiatura, di andare a capo.» – Tommaso Pincio, TTL, La Stampa
«La storia che ne nasce è una carezza che si legge in un pomeriggio e a cui val la pena di prepararsi.» – Valeria Parrella, Grazia
La storia dolce e coraggiosa di un uomo e una donna che, in età avanzata, si innamorano e riescono a condividere vita, sogni e speranze. Nella cornice familiare di Holt, Colorado, dove sono ambientati tutti i romanzi di Haruf, Addie Moore rende una visita inaspettata a un vicino di casa, Louis Waters. Suo marito è morto anni prima, come la moglie di Louis, e i due si conoscono a vicenda da decenni. La sua proposta è scandalosa ma diretta: vuoi passare le notti da me? I due vivono ormai soli, spesso senza parlare con nessuno. I figli sono lontani e gli amici molto distanti. Inizia così questa storia di amore, coraggio e orgoglio.
Locandina del film

Gruppo di Lettura – ottobre/novembre 2017
https://gdlleparole.wordpress.com/2017/10/11/19-novembre-2017/

https://gdlleparole.wordpress.com/2017/10/11/14-novembre-2017/

Nel link è presente un commento di Valeria Gramolini.
https://gdlleparole.wordpress.com/2017/10/11/17-ottobre-2017/

https://gdlleparole.wordpress.com/2017/10/11/10-ottobre-2017/
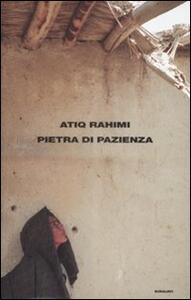
Nel link è presente un commneto di Valeria Gramolini.
Estate 2017
PESSIMA MOSSA, MAESTRO PETROSI
PAOLO FIORELLI

La misura della felicità
Gabrielle Zevin
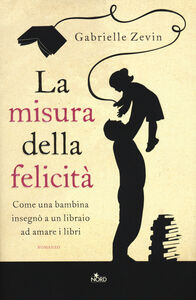
Vortici di gloria
Il romanzo degli Impressionisti
di Irving Stone

Alcuni passaggi dell’Incontro con Maura Maioli intervistata da Cinzia Piccoli
Vorrei cominciare la nostra intervista/presentazione dall'immagine di copertina del libro "Dalla mia casa non si vedeva il mare", abbiamo la persiana aperta su un paesaggio collinare distante coperto da una foschia molto significativa perché questo paesaggio appare quasi irreale della stessa consistenza dei sogni e/o che ci riporta al tema del libro.
Qual è il rapporto con la memoria

Il rapporto che abbiamo con la memoria è complesso.
Questo è un libro pieno di assenze e di fantasmi perché la storia di zia Dora, la storia che si svolge nel presente, questo pranzo, questo invito a pranzo è in realtà il sottile filo che lega insieme l'ondata di ricordi che unisce tutti i personaggi che popolano il romanzo.
Sono quattro nipoti, la zia, la badante, il pranzo è un modo per fare i conti, per ciascuno di questi personaggi, con vita attuale, il che vuol dire fare i conti con quello che si è lasciato alle spalle, con ciò che è risolto e con ciò che è irrisolto. Il rapporto con la memoria è un rapporto un po' complicato, da un lato perché la memoria permette di costruire la nostra esistenza, noi mettiamo insieme delle cose, le scegliamo nel costruirci la memoria e così fanno i personaggi, ciascuno seleziona le cose che vuole ricordare o che non vuole ricordare perché quello che uno mette insieme è il tessuto su cui costruisce la propria esistenza che giustifica ciò che è in quel momento.
Poi c'è il ricordo che arriva involontario e che riscatta un pezzo vero di passato anche quando questo passato si manifesta come doloroso.
Paul Auster scrive che "la memoria è l'unico luogo dove possiamo far accadere le cose una seconda volta" e quindi la memoria diventa la possibilità di ridare, per un attimo, vita a chi non c'è più, ripensare sul destino di qualcuno che si sarebbe voluto diverso e invece non è stato.
È una cosa con cui questi quattro nipoti fanno i conti in modo molto diverso. Quattro sono i nipoti e quattro sono le relazioni tra di loro e con il loro passato che va da chi sente il bisogno e il desiderio di ritrovare qualcosa cercando di ricucire, riscattare un rapporto con la madre; chi torna nella speranza di ritrovare, riscattare un pezzo del passato in particolare ritrovare la traccia della presenza del padre.
C'è chi considera il passato come morto quindi da non recuperare e c'è chi del proprio passato ha le ragioni del dolore presente e fare i conti con il passato vuol dire continuare a tenere aperta una ferita che non si è mai sanata.
Ciascuno dei personaggi ha un rapporto abbastanza complicato con la memoria e con questa casa in quanto casa della memoria di cui Dora è un po' la vestale, quella che cerca di tenere vivo il racconto e di tenere aperto un legame tra il prima e l'adesso.
La casa.
Possiamo definire la casa come un organismo vivente, le tracce del passato le porta impresse nei luoghi; è vero che la casa porta le tracce delle esistenze che l'hanno riempita ma è anche vero il contrario, nel momento in cui i corpi che l'hanno riempite non ci sono più, persone e oggetti, questi luoghi perdono di senso. Non siamo più in grado di riconoscerli come nostri.
È abbastanza normale che noi diamo importanza ad un luogo che ci ricorda un'esperienza significativa, incarna per noi una persona che è stata significativa, è vero che il luogo porta la traccia ma è anche vero che quando si torna nel luogo che aveva la traccia e quella cosa che lo riempiva non c'è più si avverte una sensazione di vuoto profondissima e talvolta anche di tradimento, di qualcosa che non ha restituito qualcosa che si cercava.
La casa di Dora è una casa collocata in un tempo di mezzo e in un luogo di mezzo. Di un tempo di mezzo perché ha raccolto la generazione che precede la generazione dei genitori che è emigrata dalla collina dopo la guerra, quindi contiene la generazione di mezzo rispetto alla generazione attuale dei nipoti. Un luogo di mezzo perché è in una città di mare ma non è il mare, la ferrovia lungo la costa taglia la zona in due parti, la marina con gli alberghi, la vita del lungomare popolato di turisti, e poi al di qua della ferrovia la periferia, una periferia in divenire, una periferia cantiere con i campi incolti e al tempo stesso edifici che spuntavano come funghi.
Questa casa è una casa di mezzo tant'è che sulla pagina iniziale si dice che sul davanti c'è un giardino che segna il riscatto di questa gente contadina e il desiderio di migliorarsi, alle spalle della casa c'è l'orto perché le radici si portano dietro. È un luogo che non è entrato ancora nella storia, la storia è il mare quello che diventerà l'economia dei grandi numeri e poi c'è il mito, quella terra contadina che rimane il luogo quasi leggendario.
Incontro 13 giugno 2017
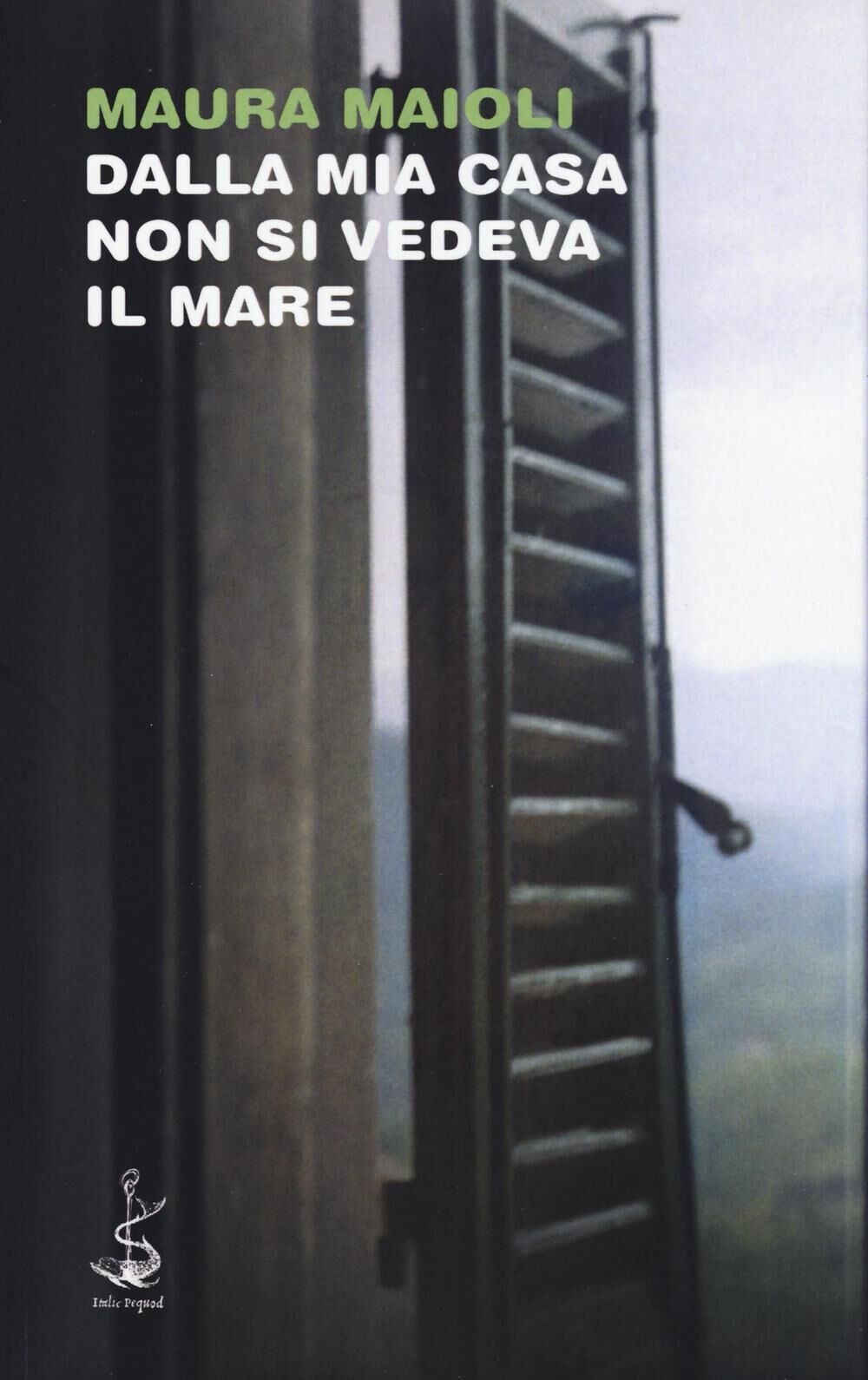
Dora ha deciso di radunare i suoi nipoti nella vecchia casa di famiglia per un pranzo. Sta cercando di venire a patti con la sua vita e gli errori che ha commesso, risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso.
La sua badante Dashulia, che la sta aiutando con i preparativi, non riesce a capire come mai sia così difficile riunire la famiglia attorno a un tavolo.
Per lei non ci sarebbe gioia più grande di stare con suo marito e i 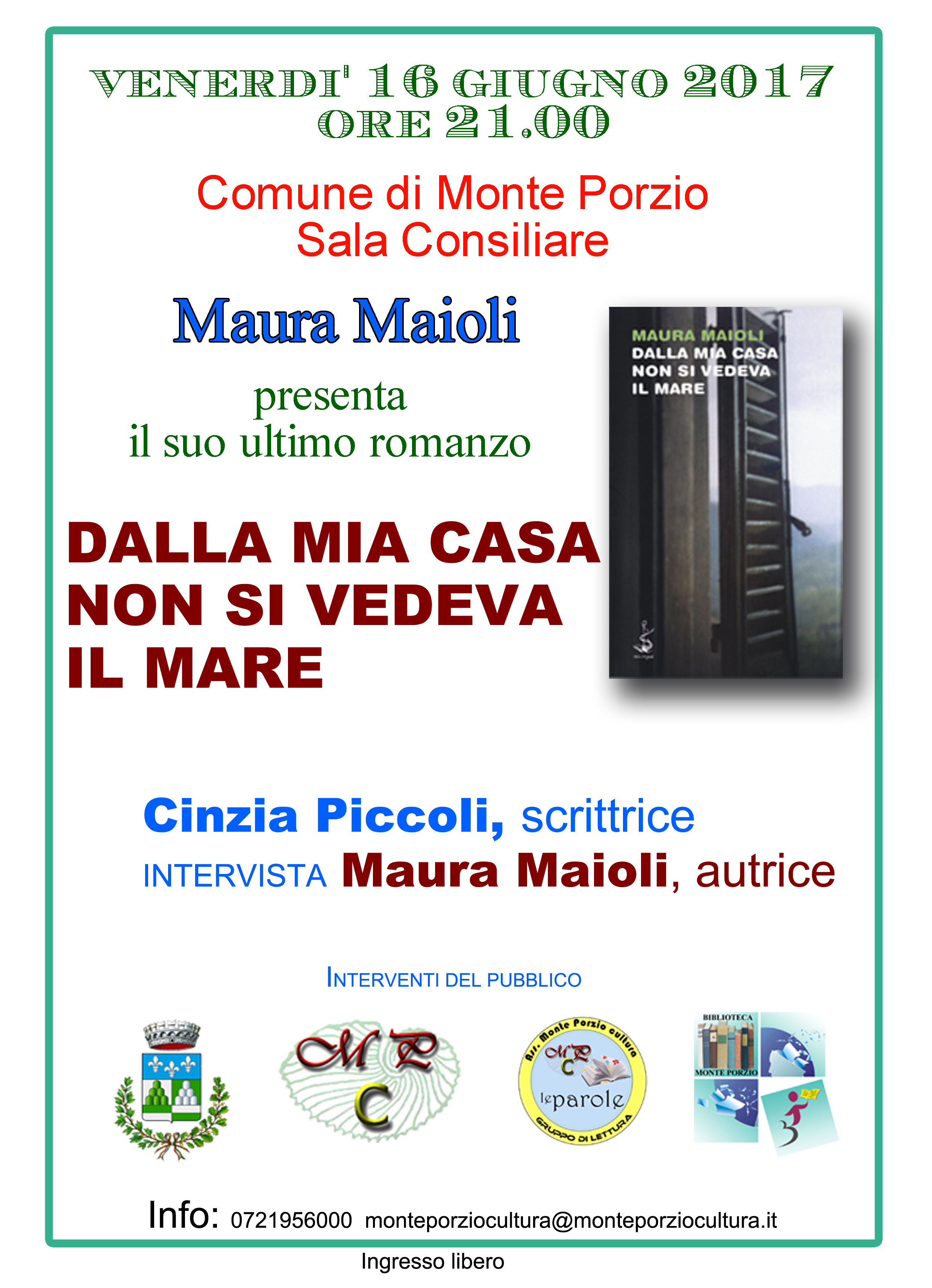 suoi figli. I nipoti, non senza ritrosie e ripensamenti, sono costretti a fare i conti con il ritorno alla casa della loro infanzia, trovandosi assaliti da ricordi che non sanno come affrontare, sentimenti che vorrebbero nascondersi ma che alla fine tornano a galla, e non c'è niente che possano fare per impedirlo.
suoi figli. I nipoti, non senza ritrosie e ripensamenti, sono costretti a fare i conti con il ritorno alla casa della loro infanzia, trovandosi assaliti da ricordi che non sanno come affrontare, sentimenti che vorrebbero nascondersi ma che alla fine tornano a galla, e non c'è niente che possano fare per impedirlo.
Nonostante gli sforzi, sembra che alla fine Dora non riesca ad ottenere ciò che più desiderava, il pieno riscatto della memoria. Ma la sua è solo in apparenza la storia di una sconfitta, perché, come scrive Maura Maioli in un'intensa nota finale, la memoria è "l'unica cosa che possiamo opporre alla morte, il solo luogo in cui gli oggetti, i luoghi e le persone con le loro storie continuano ad agire. E lì che meticolosamente costruiamo il nostro passato per opporci alla fuga del presente. E lì, sul fondo, che qualcosa resta sempre, anche dopo la fine".
Incontro con l’Autore 21 maggio 2017
L’ultimo assedio di Roberto Bernacchia (Europa Edizioni, 2015)
Trascrizione di una parte dell’introduzione di Roberto Bernacchia, dove vengono illustrate le basi storiche sulle quali si muovono i personaggi e alle quali si ispira la trama del romanzo.
Avete mai provato ad immaginare di andare indietro nel tempo per cercare di cambiare il corso degli eventi? Io l’ho fatto fin da piccolo e forse qualcuno dirà che si tratta di un esercizio un po’ infantile; questo vizio comunqu e mi è rimasto.
e mi è rimasto.
Sappiamo d’altra parte che tornare indietro è impossibile. Così sono andato avanti, cercando di immaginare un mondo sconvolto da una catastrofe di dimensioni planetarie. Qualcuno potrebbe pensare che sono stato troppo drastico, apocalittico: ‘apocalittico’ non è proprio esatto, poiché mi sono tenuto al criterio della verosimiglianza. Quello che immagino è qualcosa che potrebbe accadere (senza voler spaventare). Forse in qualche parte del mondo è già accaduto o sta accadendo qualcosa di analogo. Se pensiamo a certi scenari di guerra, di sconvolgimenti, come la Siria, l’Afghanistan, la Somalia ecc. , ci accorgiamo che non si tratta solo di materia romanzesca; se poi poteste interrogare qualcuno scampato all’assedio di Aleppo e gli raccontaste, in sintesi, la vicenda contenuta in questo libro, questo signore potrebbe pensare che quello che ho scritto nel libro è un po’ all’acqua di rose rispetto alla realtà che lui ha vissuto sulla sua pelle.
Ho cominciato a scrivere questo libro nel 2007, cioè nel momento in cui scoppiava la crisi finanziaria che poi l’anno successivo avrebbe dato il via alla crisi economica mondiale.
È da un pezzo che sto pensando che questo sistema economico, sociale, politico, imperniato sul cosiddetto primato dell’Occidente, non potrà essere eterno. Dunque, sono giunto alla conclusione che la nostra civiltà non può durare in eterno. Pensare il contrario non sarebbe scientifico: anche questa civiltà purtroppo (anzi no, è giusto così) avrà termine.
Ho cercato di raccontare come una piccola città periferica del mondo reagisce alle mutate condizioni imposte da questa catastrofe mondiale. Questa reagisce cercando di approntare nuove forme di organizzazione sociale, nuove ma in realtà si tratta di vecchie forme: per esempio si ridà slancio al settore primario dell’economia, l’agricoltura, la coltivazione dei campi e, soprattutto, alla pianificazione dello sfruttamento del suolo. Si ripristina la proprietà collettiva della terra. Questa istituzione ha una lunga storia: anche nelle fasi protostoriche dell’Italia preromana esistevano delle comunità che possedevano delle terre comuni, soprattutto delle foreste, dei pascoli. Questo regime collettivo resiste anche alla romanizzazione e poi riemerge nel Medioevo grazie all’apporto delle popolazioni barbariche. La sua storia è più lunga di quella della proprietà privata.
Un altro settore che viene ripristinato è quello dell’artigianato manifatturiero, preindustriale. Come la produzione agricola, la comunità doveva produrre tutto quanto era necessario per potersi mantenere, perché da fuori non veniva più niente. In una situazione del genere si recupera tutta una tradizione, la conoscenza del “saper fare”, saper produrre un arnese, uno strumento della vita quotidiana. In tale contesto la moneta non ha più ragione di esistere, perché ognuno lavora per sé e per gli altri, per cui gli scambi avvengono senza bisogno dell’intermediazione della moneta; alla fin fine c’è un ritorno all’economia naturale.
Qualcuno potrebbe dire che tutto ciò è bello, idilliaco. La gente riscopre il valore della comunità, della solidarietà, della coesione sociale; l’egoismo viene messo un po’ da parte. Ma, ad un certo punto, contro questa comunità si scatena un’orda selvaggia, una banda di predatori che vanno in giro a rapinare.
Anche l’economia di rapina ha una lunga storia dietro di sé: tutti i grandi imperi hanno messo in atto un’economia di rapina. Un esempio banale: anche l’impero romano rapinava le risorse delle popolazioni che riusciva a sottomettere; finché ci sono state guerre di conquista l’impero ha prosperato, quando queste sono cessate l’impero è decaduto.
E un po’ tutti gli altri imperi sono vissuti di rapina, tanto è vero che s. Agostino nel “De civitate Dei” scrive che “togliendo la giustizia, che cosa sono i regni se non grandi ladrocini e che cosa sono i ladrocini se non piccoli regni?”. Poi riporta l’episodio del pirata che viene catturato dalla flotta di Alessandro Magno e viene condotto di fronte all’imperatore che, come suprema autorità giurisdizionale, lo interroga. Ma costui ad un certo punto gli dice: “Io e te facciamo la stessa cosa, solo che tu lo fai con una grande flotta e sei chiamato imperatore, mentre io lo faccio con un piccolo naviglio e sono chiamato pirata”. Questo per dire che s. Agostino non ha voluto delegittimare lo stato, però ha anche detto che se lo stato non si basa sulla giustizia, sulle leggi, al di sopra delle quali non ci dovrebbe essere nessuno, allora diventa illegittimo.
Una possibile obiezione al mio romanzo è che io tratteggio una linea troppo netta tra il bene e il male. Forse è vero, ma mi sembrava importante fare questo in un’epoca di imperante relativismo. Credo nella verità, nel bene, e purtroppo credo pure che esiste il male. Se questa linea di demarcazione può sembrare molto netta, faccio osservare che i buoni non sono tutti uguali, nel senso che ci sono buoni che non sanno guardare la realtà così com’è e, anche se lo fanno, non hanno il coraggio di andare controcorrente. Purtroppo può capitare che la maggioranza dei buoni assecondi il male, non reagisce, ritiene che andare contro il male sia un compito che non gli compete o che sia una impresa troppo grande per loro, per degli uomini comuni.
Altri punti interessanti
Una cosa curiosa, si fa per dire, è che quella del 1517 fu guerra tra italiani, anche se fu combattuta con un supporto sostanziale di mercenari stranieri. Poteva capitare che una persona combattesse contro un amico, addirittura contro un parente. A proposito di questo possiamo descrivere una situazione realmente accaduta nell’assedio e nel sacco di Mondolfo di 500 anni fa.
Un tedesco esce fuori dalla rocca portando il piccolo Filippo Giraldi (aveva 8 anni all’epoca dell’assedio, diventò poi un cronista di questo ed altri eventi) sulle spalle a “mo’ di capretta”, incontra il capitano italiano Orsino Orsini, che era un amico di famiglia dei Giraldi, il quale riconosce il bambino e gli fa delle carezze e dice al tedesco: “Lascia questo putto che è uno dei nostri”, quello gli risponde un po’ in tedesco e un po’ in italiano che non intendeva lasciarlo cercando di proseguire il suo cammino. Il capitano gli ripete l’ordine e il tedesco mette mano alla spada, allora un soldato dell’Orsini gli trapassa il petto con l’alabarda e butta il cadavere nel fossato della rocca e libera il bambino.
In situazioni come questa i bambini venivano catturati perché era un il modo più facile per convincere i genitori a sborsare il riscatto o a rivelare dove tenevano il tesoretto di famiglia. Guarda caso, nell’esempio sopra descritto vennero catturati i rampolli di una famiglia facoltosa (oltre a Filippo, suo fratello Girolamo, catturato da un soldato spagnolo e poi riscattato dal cardinal legato, ossia dal comandante del campo), come se sapessero esattamente chi prendere (lo spionaggio durante questa guerra, e non solo, ha avuto un’importanza fondamentale).
Ad un certo punto Roberto chiede a Valeria, autrice di un bel commento sul libro: affermi che il personaggio femminile principale ricorda un po’ la Beatrice di Dante, come ti è venuta questa idea?
Valeria: Perché è una cosa romantica, una creatura molto ideale.
È la stessa idea che ho avuto io; ho cominciato a tratteggiare questo personaggio senza pensare a Dante. Ma alla fine, ripensandoci, ho capito che era venuto fuori un personaggio che più o meno aveva la stessa funzione di Beatrice, cioè di colei che guida in qualche modo il protagonista, che dà dei consigli, una persona che capisce più degli altri, forse in certi casi vede più chiaro di Ruben, anche perché è stata fuori, ha visto com’è il mondo, può confermargli una certa conoscenza, certe notizie. Comprende in anticipo quale sarà lo svolgimento successivo, gli dice; “guarda, quando comincerà a scorrere il sangue, questa unione di intenti verrà messa a dura prova”, come poi è puntualmente avvenuto.